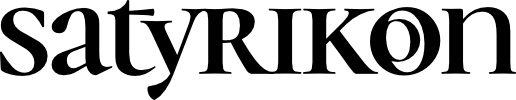Diario di Zona, quinta pagina
 Percorro le vie della città con la bicicletta ogni giorno da un anno. Non pensavo fosse possibile andare caparbiamente in giro anche con la pioggia, la neve, il freddo e invece… La cosa difficile non è farlo con la pioggia, o con il ghiaccio sotto le ruote. La cosa difficile è avere a che fare con il traffico. Con le auto che ti sfrecciano a pochi centimetri dai pedali, costringendoti a sfiorare marciapiedi, auto parcheggiate. Altra cosa difficile: evitare le buche. La mattina molte persone hanno fretta, altre parlano al telefono, altre ti guardano sprezzanti o non ti vedono proprio o ti mandano affanculo. Per non parlare degli imbecilli fanatici della sequenza “prima-seconda-terza tiratissima” che frenano a 10 metri dal semaforo, immancabilmente rosso.
Percorro le vie della città con la bicicletta ogni giorno da un anno. Non pensavo fosse possibile andare caparbiamente in giro anche con la pioggia, la neve, il freddo e invece… La cosa difficile non è farlo con la pioggia, o con il ghiaccio sotto le ruote. La cosa difficile è avere a che fare con il traffico. Con le auto che ti sfrecciano a pochi centimetri dai pedali, costringendoti a sfiorare marciapiedi, auto parcheggiate. Altra cosa difficile: evitare le buche. La mattina molte persone hanno fretta, altre parlano al telefono, altre ti guardano sprezzanti o non ti vedono proprio o ti mandano affanculo. Per non parlare degli imbecilli fanatici della sequenza “prima-seconda-terza tiratissima” che frenano a 10 metri dal semaforo, immancabilmente rosso.
La cosa difficile è difendere il diritto di stare in strada, visto che le piste ciclabili non ci sono o, dove ci sono, se non si interrompono alle soglie di un dehor finiscono e basta.
Scelte: strada o marciapiede? Prendo la buca o mi spalmo sulla macchina a destra?
Si va di fretta, facendo attenzione, fra utilitarie e furgoncini, SUV e camion pesantissimi. Penso a cosa potrebbe accadere se sfiorassero la ruota della bici e vedo un volo di diversi metri dritto fra le braccia accoglienti della coppia “asfalto & cemento”. E infine: attenzione al giallo, a Torino è il segnale che dice agli automobilisti “accelera, accelera, accelera”.
In piazza della Repubblica ogni mattina c’è il mercato. Passo fra la gente attento ai pedoni, ai cani, alle bottiglie. Su un muro leggo: Sans papiers, sans travaille, sans maisons? Bourdel dans le Rou!
Zone 810, 812, Basso San Donato: C.so Regina Margherita / C.so umbria / C.so Gamba / C.so Tassoni
Nel quartiere, attaccato alle porte di quasi tutti i palazzi, c’è un volantino di un’associazione di quartiere che chiede un incontro col neo sindaco per risolvere lo stato del quartiere definito come “zona morta, degrado, paura, sporcizia e abbandono”. Non vedo degrado, vedo che molti negozi sono chiusi, che molte persone passeggiano a testa bassa. In molti rispondono a muso duro. Sento che c’è diffidenza, come in molte altre zone della città. Per la serie: Chi sei? Che vuoi? Perché stai suonando al mio citofono?
Non ce l’ho le chiavi!
Senta, mi hanno detto di chiedere a lei.
Ah si?
Sì.
Allora vengo.
Cominciamo bene, penso.
Viene giù. Panza strabordante e accento pugliese. Mi segue in cantina, mi guarda scattare la foto, digitare la lettura
Com’è messo a consumo?
Basso.
Eh, era ora. Abbiamo chiuso il contatore che buttavano acqua a tutt’andare. Ha voglia che ci dicevi che l’acqua costa cara, lavavano co ‘a pompa in mezz ‘o cortile ma niente, gentaglia. E quant’è ù comsumu?
Non lo so, ho solo un’indicazione di massima. Comunque è basso.
Eh sì. Abbiamo speso settemila euri. Ma mò, non c’è nessuno. Al terzo piano un c’è nessunu. I miei vicini se ne sunu juti puru. Sò tornati ai paesi loro.
Per lavoro?
Mah! In Germania, in Francia, da parenti. Basta che non rompono le palle all’Italia.
Vado a dare un’occhiata ai nomi scritti sulle targhette del citofono: 13 su 20 suonano non italiani, i restanti suonano non piemontesi: perché non se ne sono tornati “alle regioni loro”?
A ciascuno il suo, usando lo stesso algoritmo ghettizzante.
“Animali da lavoro. Operatori per i computer, le macchine riproduttive, le incubatrici. Manovali per attività manuali, che in questa specie, come insegna la loro storia, avevano sempre goduto di una stima estremamente bassa. Io, rappresentante di un popolo che non è costretto a svolgere alcuna attività manuale (d’altra parte non disponiamo neppure di qualcosa come “mani”!), purtroppo non riesco ad immedesimarmi troppo bene. Ma mettiamoci una pietra sopra!” da Le Api Re di Elfriede Jelinek
Guardo le strade di questa parte della città, guardo le persone, i muri. Passo da un portone all’altro, è la terza volta che lavoro in questa zona, inserisco il pilota automatico.
Il mio istinto mi dice che nell’aria c’è un’atmosfera strana, scelgo una modalità di basso profilo, mi limito a parlare il minimo indispensabile.
Uomo sui 50 anni, con passo pesante viene giù, non è ancora arrivato al pianerottolo del primo piano che a voce alta dice:
Sempr’ammè.
Non viene nessuno, eh?
Sempre noi scendiamo.
Test’ di cazz’ e condominio tutti quanti.
Che se ne fregano.
Che poi, che cazz’ devono rubbare? Debbiti? Pidocchi?
(Niente, io non dico niente, entro in cantina, lavoro e torno su; lui sta ancora borbottando qualcosa)
Buongiorno e grazie, dico.
Buongiorno e buon lavoro, mi fa lui.
Sì, come no?
In via Don Bosco al n° 47 sta sbiadendo lentamente sul muro un “Berlusconi 6 una merda”
Sono fermo sul marciapiede, sto prendendo un appunto per un ‘ripasso’ da fare domani: due contatori sono nella cantina di un’osteria che il lunedì è chiusa. Non lo sento arrivare, da dietro la spalla sinistra mi arriva la voce che fa:
Cercavo un italiano e ci sono solo stranieri.
Passato il primo momento di incredulità dico: Prego?
Cerco Salvatore e non lo trovo, sono tutti stranieri.
Ho appena suonato a quel citofono, lo so che non è come dice lui, potrei lasciare perdere e invece non mi va di lasciare passare la cosa. Vado al citofono e dico:
Veramente qui abitano molti italiani. E comincio ad elencarli.
Ah si? dice, e si avvicina a leggere.
E allora? Chi sta cercando?
Mah, so che si chiama Salvatore e qui le iniziali sono diverse. Si vede che non c’è.
Detto questo va via.
Mi guardo intorno nella speranza di veder spuntare da dietro un angolo Pozzo e Lucky e poter dare un senso a questa settimana.
Torno sulla bici e mi sposto su c.so Regina, entro in un bar per concedermi un caffè e leggo la prima pagina del maggiore quotidiano cittadino. Molti articoli dedicati alla “questione” NO TAV. La cosa che mi indispettisce è che dopo le prime righe è facile intuire dove andrà a parare il giornalista. E penso di star sprecando il mio tempo a leggere articoli reazionari, contenutisticamente e stilisticamente poveri.
Un’oceano di veleno e un’accozzaglia di puttanante.
Mi preparo per la manifestazione del 25 febbraio in Val di Susa.
In via Don Bosco incontro al targa al Ten. Partigiano Giuseppe Bravin
In zona c’è uno studio di commercialisti che occupa un edificio intero. Per poter leggere il contatore devo accedere all’intercapedine, scendere nel piano interrato dove, ricordo, c’è un ufficio con 3 scrivanie e sui muri poster di Antonio Banderas, George Clooney, Johnny Deep. Suono al citofono, entro e trovo un’unica dipendente alla reception, è al telefono con un cliente. Termina la telefonata e mi accompagna giù dove vedo che non c’è nessuno a lavorare, le luci sono spente e fra le scrivanie vuote ci sono solo scatole ammucchiati al centro dell’open space.
Scusi per il freddo, mi dice, stiamo trasferendo l’archivio. Hanno licenziato un po’ di persone.
Ricordo che qui stavano in tre a lavorare.
Non hanno guardato in faccia a nessuno, mi dice, anche dopo 30 anni di lavoro hanno licenziato senza starci a pensare, dicono che non stanno guadagnando abbastanza. E tutti i soldi che hanno guadagnato fin’ora? Le garantisco che hanno guadagnato e guadagnano ancora. Andrò in pensione fra cinque anni, spero, almeno.
Mi parla tenendo le braccia intrecciate come se si stesse abbracciando, non so se per il freddo o per altro.
Apro la porta che separa l’ufficio dall’intercapedine, sposto un po’ di ragnatele e scatto la foto sperando che il palmare faccia il suo lavoro, torno dentro.
Torniamo su parlando della differenza che esiste fra datori di lavoro e dipendenti. Parliamo di stipendi, pensioni, delle riforme da strozzini che stanno per arrivare. E mi racconta che un cliente dello studio, un primario nonché professore universitario e libero professionista con tre pensioni, non trovava un CUD di una pensione integrativa e le disse:
ma lasci perdere, per quella miseria.
La miseria ammonta a 600€ al mese – fa notare la signora allo stimato professionista – cifra che per molti è l’unica pensione. Ma per lui che ne riceve 250.000€ l’anno, certo che è una miseria.
Quante ne ho viste lavorando qua dentro, mi dice ancora. Si figuri, c’era un medico, un dentista che fatturava tutto, tutto. Arrivava qui con colonne di blocchetti per ricevute. Voleva dormire tranquillo, ci diceva. Fatturava e pagava tutto. Diceva “Guadagno bene, perché non dovrei pagare?” Ecco, venne “chiamato” da, diciamo, una lobby. In pratica venne richiamato perché fatturava, lui col suo studio piccolo e due dipendenti, più di quanto dichiaravano i colleghi che avevano studi che prendevano appartamenti interi con sette/otto dipendenti. Ha ricevuto minacce, hanno messo in giro voci per screditare il suo lavoro, ma lui niente, se n’è fregato. È andato in pensione a 55 anni. E qui adesso stanno licenziando, vediamo finché dura.
Suona il telefono, saluto e torno in strada.
L’italiano che si parla a Torino è zeppo di inflessioni meridionali (pugliese, campano, calabrese, siciliano) ma anche una certa influenza dei dialetti dell’area nord orientale, oggi così ricca e prospera (leggere Gomorra di Saviano per intuire il perché) ma anni fa terra di emigrazione (leggere Canale Mussolini di Pennacchi). Insomma c’è una parte della popolazione di Torino che ha una parlata strana, un mix che non so definire, sembra sempre interrogativa. Non so se rende, la trascrivo così:
In questa casa (?), in questa palazzina (?), se non scendo io (?) non scende nessuno (?,) tutti se ne sbattono i coglioni (?).
Noto che la GTT (quelli della stretta ai clienti e la mano ai controlli) ammicca alla stessa parlata in uno spot il cui incipit è: Sai che c’è? Io mi faccio etc etc.
In via Livorno c’è una scuola materna, un contatore è nella caldaia, un altro sotto una finestra in uno stanzone dove di solito per raggiungerlo devo fare lo slalom fra i lettini per i bimbi. Percorro il corridoio, i bambini mi guardano con aria incuriosita, che ci fa qua “un papà” sembra si chiedano, sorrido del mio pensiero e guardo i loro disegni che celebrano il 150° dell’unità d’Italia, guardo le loro foto, leggo i nomi scritti sugli armadietti: Filippo, Jasmine, Alessandro, Ruth, Sebastian, William, e mi ritrovo a pensare che l’integrazione è pratica quotidiana nelle aule delle scuole, degli asili dove bambine e bambini giocano lo stesso gioco e condividono la stessa esperienza, con buona pace dei nazi in camicia verde.
Ho due contatori un po’ fuori zona, a volte capita, con la bicicletta è una passeggiata di 5 minuti, a piedi perderei un bel po’ di tempo e dovrei camminare parecchio. Uno è al centro della rotonda che da via Livorno immette sul nuovo ponte sulla Dora, l’altro è in un pozzetto poco lontano nei pressi dell’Environment park, che è parecchio profondo. Se il primo è un po’ difficile da raggiungere a causa del traffico, ma decisamente agevole perché è in un tombino poco profondo, il secondo è poco lontano dalla strada ma in un posto profondo e di non facile apertura. Di solito mi limito a tirare su la botola e scattare solo una foto dall’alto. Il contatore è solo un puntino al centro della foto, non si legge nulla a meno che non riescano a ingrandire la foto sullo schermo di un pc. Questa volta penso di provarci ad andare giù, il cemento non è liscio e gli appigli ci sono, perché non provare. Individuo i punti di appoggio, vado giù e scopro che scendere non è poi difficile quanto immaginavo, e anche risalire non è una gran fatica. Tutto sta nel provarci, mi dico, le cose cambiano cambiando anche punto di vista.
Ciò che prima detestavi, adesso ti affascina, e quel che ti spaventava ora t’incuriosisce. Da Gli Psicoatleti di Enrico Brizzi
Il palmare fa le bizze, o meglio, qualcosa non va sia dal punto di vista hardware (sembra che la batteria non regga e dopo poche ore di lavoro la cosa appare molto strana) che software (non posso salvare le foto). Attaccato al telefono col caposquadra cerchiamo di risolvere almeno il problema del salvataggio delle foto, ma non c’è niente da fare. Mi devo fermare, e dopo un’ora mi portano un nuovo terminale che non va proprio bene, mi dice F. sorridendo, ma un’altro al momento non c’è. Lavoro bene per un po’ di ore, senza sforzo sto recuperando il tempo perso. Nessuno mi ha chiesto di “recuperare” ma il fatto di lavorare in una zona che conosco rende la cosa possibile senza che stia a inseguire un risultato. Fino al momento in cui il palmare si pianta un’altra volta. Impreco, resetto tutto e riavvio. Il padrone dell’officina in cui sto facendo la lettura è lì a due passi da me, osserva tutto e mi dice serafico:
Non andava bene carta e penna. No, ora siamo nell’era del softer.
Sia maledetto il softer, dico io.
Lui sorride, fumando la sua sigaretta.
Il problema vero è che non ho neppure un libro con me. Mi fermo e basta. Mi trovo in via Capua davanti alla sede del comitato Parco Dora fermo ad aspettare che arrivi qualcuno con un palmare funzionante. Dalle vetrine osservo piantine, prospetti, grafici.
Riprendo il lavoro che è ormai tardi, di solito a quest’ora sto tornando a casa. Attraverso al strada e suono al citofono. Risponde una signora che mi apre, viene giù e mi chiede minacciosa: Chi è lei, che è stato tutto sto tempo lì fermo? Chi è? uno poco rassicurabile?
Inforco la bici
Torno a casa
Cantando stonato
“I can feel death, can see it’s beady eyes…
And fade out again and fade out again”
In c.so Principe Oddone angolo c.so Regina, un caro signore col suo SUV non rispetta la precedenza e mi taglia la strada. Freno, le ruote lasciano un piccolo segno sull’asfalto, lo mando affanculo e mi fermo sotto la targa dedicata a Franco Piccone, partigiano.
And fade out again and fade out again
Radiohead Street Spirit (Fade Out) [con piccolo errore del grande Tom]