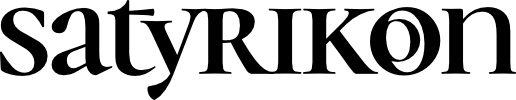Sul teatro e sugli attori
di Elfriede Jelinek
Non voglio recitare né stare a guardare altri che recitano. Non voglio nemmeno spingere altri a recitare. La gente non dovrebbe dire e fare cose come se fosse reale. Non voglio vedere riflessa nelle facce degli attori una falsa unità: quella della vita. Non voglio vedere il gioco di forze di questo „muscolo bene ingrassato“ (Roland Barthes) fatto di parola e movimento – la cosiddetta „espressione“ dell’attore di mestiere. Movimento e voce, non vorrei farli andare insieme. […] L’attore imita inutilmente l’uomo, varia l’espressione e si cava via di bocca un’altra persona, con una storia che viene dilatata. Io non voglio richiamare in vita degli estranei davanti al pubblico. Non so bene, ma non voglio un gusto sacrale di divinità richiamata in vita sul palco. Non voglio teatro. Forse voglio solo mettere in mostra delle attività da esercitare per rappresentare qualcosa, ma senza un senso più elevato. Gli attori dovrebbero dire quello che altrimenti non dice nessuno, perché non è mica vita quella. Devono mostrare lavoro. Devono dirci cosa sta succedendo, ma che non ci vengano a raccontare che in loro avviene tutt’altro, un qualcosa che si può leggere indirettamente nei loro volti e nei loro corpi.
[…] Chi può dire quali sono le figure deputate a portare a compimento l’atto verbale a teatro? Io ne faccio schierare a volontà una contro l’altra, ma chi è chi? Io non le conosco mica, queste persone! Chiunque può essere un altro ed essere interpretato da un terzo, che è identico a un quarto senza che se ne accorga nessuno. Un uomo dice. La donna dice. Un cavallo va dal dentista e racconta una barzelletta. Non li voglio conoscere. Arrivederci.
[Da “Ich möchte seicht sein” („Vorrei essere superficiale“),
in: Theater Heute Jahrbuch 1983, S. 102.]
Io voglio che gli attori facciano tutt’altro. Voglio che la parola non sia un abito, ma resti sotto l’abito. Qualcosa che c’è, ma non spinge per emergere, non sbuca da sotto l’abito. Al massimo può conferire all’abito una certa stabilità, che però, come quella dell’imperatore, sparisce subito, svanisce come fumo (nonostante un attimo prima fosse stabile), per fare posto a qualcosa di diverso, di nuovo. Come sabbia sotto il lastricato, così sotto il lastricato la ferita sempre aperta, la parola. Detto diversamente: io li butto nello spazio come bastoncini di shangai, questi uomini e queste donne a cui sono ancora appesi agli angoli della bocca brandelli di Heidegger, Shakespeare, Kleist, fa lo stesso chi, dove cercano invano di nascondersi dietro nomi altrui, ovviamente molto spesso il mio; e, senza essere toccati, dovrebbero poi toccarci, gli attori, ma a nessuno è concesso tremare, uscire dal seminato, essere urtante. Beh, urtare possono pure. Lo dico perché tanto è una cosa che non cambierà mai. Ho già detto tante volte che non voglio teatro da loro. Perché quando fanno teatro compromettono, come succede con l’incontro col proprio Io, in sogno, davanti allo specchio, negli occhi dell’amante, allora compromettono il rapporto che hanno l’uno con l’altro e il rapporto con quello che dicono, ossia pensano, ossia dovrebbero essere. Però non possono nemmeno voler essere se stessi. Il peggio è quando cercano di fare collimare quello che dovrebbero diventare con quello che sono già. La sfida invece consiste molto più nel fatto che loro, come prosciutti color carne che non tanto hanno l’aspetto di carne, ma sono proprio carne, appesi nell’affumicatoio, nel vano di un’altra dimensione, che non è realtà, ma nemmeno teatro, ci trasmettano qualcosa, una notizia i principianti, un messaggio i più esperti. E allora si accorgono di essere essi stessi il proprio messaggio. […] Ciascuno è se stesso. Sono quello che sono. Come Dio, che è quello che è. È un compito bello e importante, no? Gli attori SONO la parola, non parlano. Ma dal momento che sono in tanti, in molti, e possono mandarmi al tappeto e dichiararmi sconfitta senza problemi, devo disorientarli, confonderli, mettergli sotto un Dire estraneo, le mie amate citazioni, che ho chiamato a raccolta per poter diventare di più e poter fare più punti anch’io di quanto non abbia potuto finora che ero sola. A ciascuno il suo, a me invece tutto [… ]. Naturalmente io voglio essere di più è più grande di quanto non sia; per questo vengono qui, per questo mi arrivano giusto a puntino, i vari figli dei vicini: Fichte, Hegel, Hölderlin, e costruiscono un muro babilonico insieme a me. Devono inserirsi, devono unirsi a me, c’è poco da fare, altrimenti gli taglio via un pezzo dal loro piedistallo. E gli attori sono talmente ambiziosi, che cercano di saltellarci ancora sopra, da non crederci! […] Così non va, Signor e Signora attore! […] Se è così vado a chiamarne un altro, un’altra, tanto ce ne sono abbastanza di voi! Si, ne abbiamo abbastanza di voi! E così carico l’attore con la sfida del mio linguaggio, mescolo le pretese infinite di almeno altri duecento autori, che sono stati grandi e hanno davvero vissuto, anche se oggi ci sembrano irreali, e mescolo infine anche le mie [… L’attore] deve percepire il mio diritto e allo stesso tempo deve poterlo ignorare, per diventare qualcuno che a sua volta fa valere i propri diritti. E casualmente poi questi sono anche i miei, gli stessi che ho rivendicato tutto il tempo! Bravo! Adesso ha fatto la cosa giusta. Finalmente l’ha capita. Adesso lui è me, ma senza insistenze e senza insistere per essere ciò che dovrebbe interpretare. […] Immobilizzato nei binari della mia scrittura, finché non esce, deraglia, va a sbattere contro la foresta e viene poi riportato alla luce nelle vesti di tutt’altra persona. Tengo alta la mia lampada, per fargli ancora un po’ di luce, ma adesso è definitivamente scomparso, che io lo voglia o no.
[Da “Sinn egal. Körper zwecklos”
(„Senso indifferente. Corpo inutile“), 1997.]